Dalle differenze biologiche ai fattori socioculturali, la Medicina di genere rivoluziona l’approccio alla cura, puntando su diagnosi più accurate, trattamenti personalizzati e maggiore equità tra uomini e donne.
La Medicina di genere è un approccio innovativo alla prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie che prende atto dalle differenze biologiche, ormonali, genetiche (ma anche sociali) tra uomini e donne. Questa disciplina si basa sull’idea che il genere influenzi in modo significativo la manifestazione delle patologie, la risposta ai farmaci, gli esiti clinici, le modalità della riabilitazione e ogni altro aspetto clinico, rendendo necessario un adattamento delle strategie mediche per garantire cure più efficaci ed eque.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità chiarisce che oltre alle chiare (ma troppo spesso ignorate) differenze biologiche tra maschio e femmina, esistono differenze legate all’identità, al ruolo sociale, al lavoro svolto, al posto dove vive, alla religione, eccetera. Ogni singolo costrutto sociale influenza (o dovrebbe influenzare) l’approccio che il Medico deve avere rispetto al singolo Paziente. La medicina di genere, pertanto, non si limita a considerare le sole differenze biologiche legate al sesso, ma abbraccia anche l’influenza dei fattori socioculturali e ambientali. Essere uomini o donne, infatti, determina il diverso accesso ai servizi sanitari, l’aderenza alle terapie e le abitudini di vita, che possono incidere sulla diffusione e la gestione di molte malattie croniche. Per questo motivo, è fondamentale integrare la prospettiva di genere nella ricerca scientifica, nelle linee guida cliniche e nei percorsi di cura, in modo da migliorare la personalizzazione dei trattamenti e l’efficacia della medicina moderna.
Il caso dell’infarto miocardico
Fino ad oggi la ricerca medica e farmacologica si è basata su campioni di popolazione maschile, considerando l’organismo femminile come una semplice variante di quello maschile. Questo ha portato a molti danni ed errate valutazioni nella sintomatologia, nei fattori di rischio, nella risposta ai trattamenti, negli effetti avversi dei farmaci, con il consolidarsi di errori ed equivoci.
L’esempio più noto è quello dell’infarto miocardico: considerato fino a pochi anni fa un problema prevalentemente maschile, si manifesta in modo diverso nelle donne, spesso con sintomi atipici che ritardano la diagnosi e l’intervento terapeutico.
All’infarto viene sempre associato il classico dolore toracico intenso e oppressivo che si irradia al braccio sinistro, la sudorazione fredda e la difficoltà respiratoria. Certo. Però questa è la sintomatologia maschile. Nelle donne i sintomi sono diversi e possono essere facilmente confusi: il dolore toracico, se presente, è poco intenso e localizzato nella schiena. Altri segnali sono un affaticamento improvviso e inspiegabile, nausea e vomito, un dolore che può localizzarsi al collo, alla mandibola o tra le scapole. Inoltre, molte donne sperimentano una sensazione di angoscia o ansia improvvisa, simile a un attacco di panico.
Tutti sappiamo quanto un intervento medico tempestivo sia fondamentale per salvarsi la vita in queste circostanze. Ecco perché questa differenza di sintomi è un problema reale e concreto. Se negli uomini l’infarto è spesso riconosciuto rapidamente, nelle donne può passare inosservato, con conseguenze anche fatali. Aumentare la consapevolezza sulle diverse manifestazioni dell’infarto è fondamentale ed è una delle missioni della Medicina di genere.
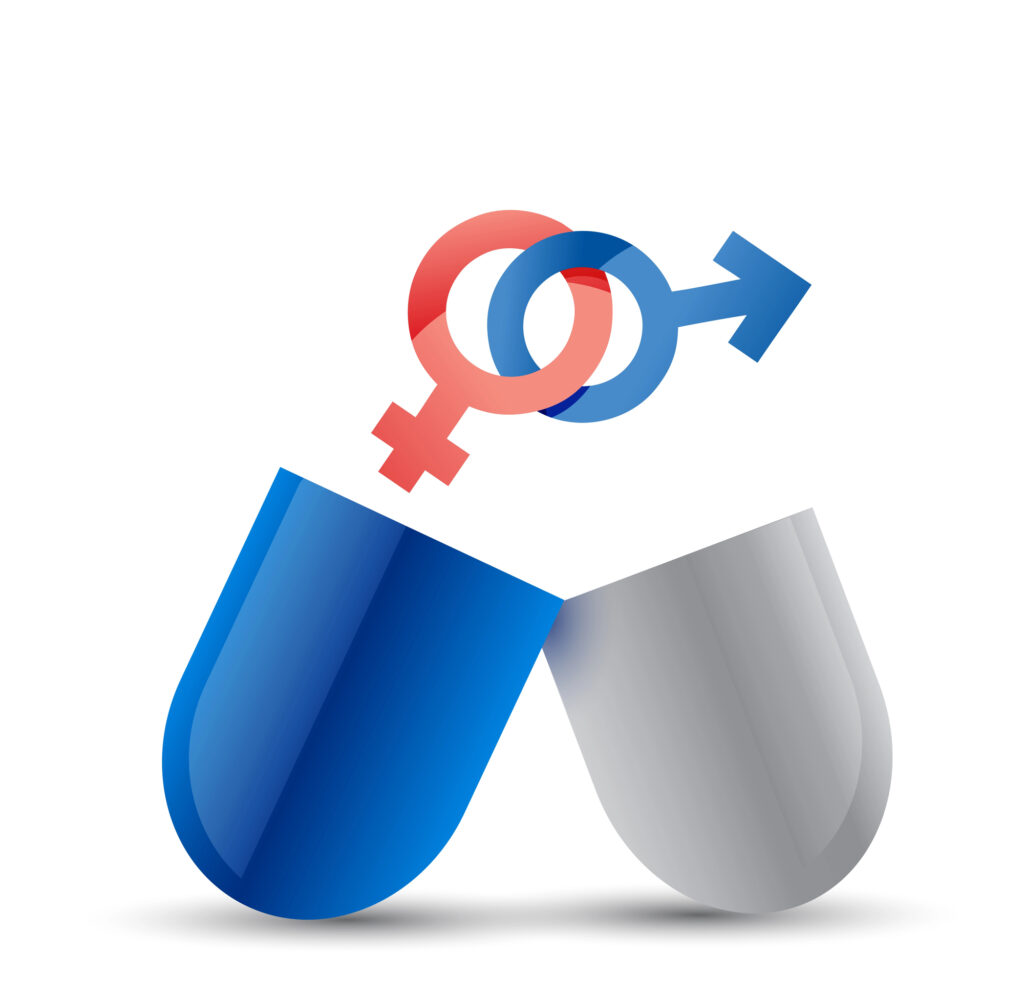
Genesi della Medicina di genere
Non a caso la sua prima formulazione è stata opera di una Cardiologa, l’americana Bernardine Healy, allora Direttrice del National Institute of Health, che nel 1991 pubblicò sul New England Journal of Medicine un editoriale intitolato The Yentl Syndrome. In questo studio, Healy evidenziava come uomini e donne ricevessero un trattamento differente per le patologie coronariche, con un minor numero di interventi diagnostici e terapeutici nelle donne, portando così a un diverso approccio clinico e terapeutico. Da questa osservazione è emersa la necessità di una nuova prospettiva nella medicina, che tenesse conto delle differenze biologiche, socio-economiche e culturali nel determinare lo stato di salute e di malattia.
Oggi la medicina di genere o, più correttamente, medicina genere-specifica, rappresenta un nuovo approccio clinico in grado di migliorare l’appropriatezza delle cure e la promozione di una medicina basata sulle evidenze, in grado di contribuire ad una gestione più efficiente delle risorse sanitarie, garantendo equità e qualità nei percorsi di prevenzione, diagnosi e trattamento.
Nel 2006 è stata fondata a Berlino la Società Internazionale di Medicina di Genere (IGM), con l’obiettivo di promuovere a livello internazionale questa disciplina e incoraggiando la ricerca nella medicina clinica e nella sanità pubblica.
Il problema dei farmaci
Esistono differenze significative nella risposta ai farmaci tra uomini e donne, dovute a vari fattori: il metabolismo, la distribuzione corporea dei farmaci, la funzione epatica e renale, e la regolazione ormonale. Differenze che influenzano l’efficacia dei farmaci e i loro effetti collaterali. Ad esempio, le donne metabolizzano alcuni farmaci più lentamente degli uomini a causa di un’attività ridotta di alcuni enzimi epatici e questo può portare a una maggiore concentrazione del farmaco nel sangue, con un aumento degli effetti collaterali. Poi le donne hanno una percentuale di massa grassa maggiore rispetto agli uomini, il che può influire sulla distribuzione dei farmaci lipofili prolungandone l’effetto e aumentando il rischio di tossicità. Le donne tendono ad essere più sensibili agli oppioidi, sperimentando effetti collaterali come nausea e vertigini con maggiore frequenza rispetto agli uomini, mentre il paracetamolo è metabolizzato in modo diverso nei due sessi. E si potrebbero fare decine di altri esempi… L’aspetto più importante è che, finalmente, la farmacologia sta iniziando a porsi il problema della personalizzazione delle terapie considerando le specificità biologiche di ciascun sesso. Di conseguenza, sempre più studi clinici stanno includendo un’analisi differenziata, per garantire che uomini e donne ricevano cure farmacologiche adeguate alle loro caratteristiche biologiche.


